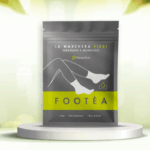La notte del 31 ottobre è universalmente riconosciuta come un momento di confine, dove il mistero avvolge le tradizioni e le credenze di molte culture. In questa particolare notte, il velo che separa il mondo dei vivi da quello dei morti, secondo la tradizione celtica e altre visioni spirituali, si fa più sottile. Questo periodo rappresenta una sorta di “porta” che consente una comunicazione più intima con il mondo spirituale, favorendo il ricordo dei defunti e il legame con le proprie radici ancestrali.
Origini antiche e significato esoterico
Il 31 ottobre non è solo la vigilia di Ognissanti per il calendario cristiano, ma anche la data in cui i Celti celebravano la festa di Samhain, considerata il capodanno celtico. Il termine Samhain, derivato dal gaelico “samhuinn”, significa letteralmente “fine dell’estate”, e segnava il momento in cui le comunità pastorali tornavano dalle montagne con le greggi, preparandosi al riposo invernale e alla nuova annata. Durante questa notte, tutte le restrizioni tra il mondo visibile e l’aldilà venivano meno; si pensava che gli spiriti dei defunti potessero vagare tra i vivi, facilitando la comunicazione con chi non c’è più.
Parallelamente, molte altre culture celebravano in questo periodo riti di passaggio o di commemorazione dei morti, come il Día de los Muertos in Messico, valorizzando il rapporto con gli antenati e la ciclicità della vita e della morte. Anche l’uso delle lanterne, delle maschere e dei fuochi rimanda a antichi riti di protezione contro le forze oscure della stagione fredda e dell’inverno, che con la loro oscurità rappresentavano l’ingresso negli inferi secondo molte tradizioni.
Simbolismo e rito: il confine tra mondi
Il nodo centrale della notte del 31 ottobre è la percezione di un confine sfumato tra il mondo materiale e quello astrale, tra il visibile e l’invisibile. Per questo motivo in molte tradizioni spirituali si prega, si rende onore ai propri antenati e si compiono rituali di purificazione. La credenza celtica narra che le leggi fisiche che governano lo spazio-tempo vengano sospese, permettendo la fusione tra la realtà terrena e quella ultraterrena.
Leggende tramandano che gli spiriti erranti di chi è morto durante l’anno tornino la notte del 31 ottobre in cerca di un corpo da possedere per il ciclo successivo. Le comunità indossavano quindi abiti spaventosi e maschere, sia per allontanare gli spiriti maligni, sia per confondersi ed evitare di essere riconosciuti dagli spiriti stessi. Questi costumi, uniti alle danze attorno ai fuochi, avevano la funzione di protezione ed esorcizzazione della morte e dell’ignoto.
Halloween: evoluzione di una festa pagana
Oggi, la notte del 31 ottobre è conosciuta in tutto il mondo come Halloween, una festività nata da radici profondamente spirituali e pagane, ma trasformata nel tempo in un evento di costume, divertimento e socialità. Il termine Halloween deriva da “All Hallows’ Eve”, la vigilia di Ognissanti, e la sua diffusione nei paesi anglosassoni, soprattutto negli Stati Uniti, ha aggiunto elementi nuovi come il “dolcetto o scherzetto”, le decorazioni ‘da brivido’, le zucche intagliate (le famose jack-o’-lantern che rievocano antichi rituali delle lanterne vegetali) e il tema della paura.
Nonostante la commercializzazione, la festa mantiene una forte connessione con il suo significato originario: la celebrazione della fine del ciclo annuale della natura, il confronto con la propria mortalità e il ricordo dei propri cari. In Italia, la “notte delle streghe” ha sempre più successo; locali, piazze e luoghi pubblici si riempiono di eventi e decorazioni, creando un’atmosfera misteriosa e incantata.
Atmosfera e tradizioni contemporanee
In molte culture europee e soprattutto nei paesi anglosassoni, la notte del 31 ottobre viene vissuta tra terrore e festa, tra il bisogno di esorcizzare la paura della morte e quello di celebrare la vitalità della comunità. I colori tipici di Halloween, l’arancione e il nero, ricordano la fine dei raccolti e l’inizio dell’inverno, evocando il passaggio dalla luce all’oscurità e il ciclo perenne di rinascita.
L’attività culminante per i più piccoli, il “dolcetto o scherzetto”, affonda le sue radici nella credenza che offrire dolci ed ospitalità agli spiriti (o ai bambini travestiti da spiriti) sia un modo per propiziarsi la buona sorte per il nuovo anno. Le decorazioni con zucche, fantasmi, pipistrelli e scheletri sono tributi simbolici al mondo dell’aldilà e all’universo del mistero.
Riti, superstizioni e spiritualità: cosa si fa la notte del 31 ottobre
- Preghiere e onori ai defunti, sia nel privato che in ritualità collettive.
- Accensione di fuochi e lanterne per illuminare le tenebre e tenere lontani gli spiriti maligni.
- Indossare maschere e travestimenti per confondere gli spiriti e proteggere se stessi.
- Preparare dolci tipici, offrendo ed accettando piccoli doni come auspicio di abbondanza.
- Partecipare a raduni, feste in costume e attività ludiche ispirate all’occulto.
Durante questa notte, si rinnova la memoria del ciclo della vita e della morte, abbracciando la propria paura per l’ignoto e celebrando la speranza di rinascita. Il senso profondo della notte del 31 ottobre, dunque, non si esaurisce nella dimensione folkloristica: resta uno dei momenti più intensi e magici per riflettere sul mistero dell’esistenza, sul rapporto tra i mondi e sull’invisibile che circonda la realtà visibile.